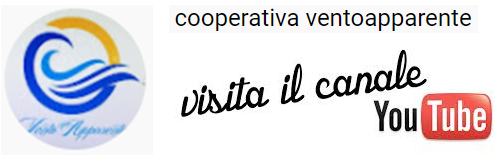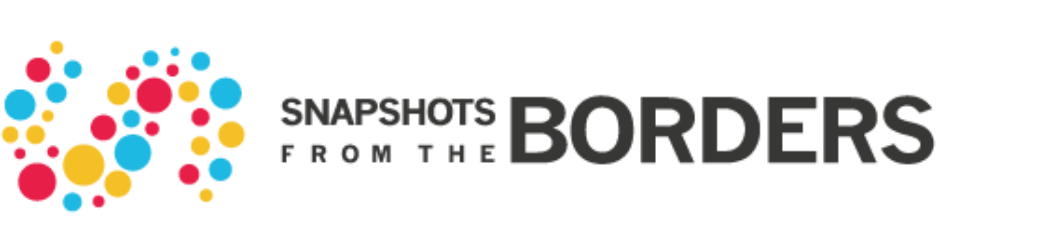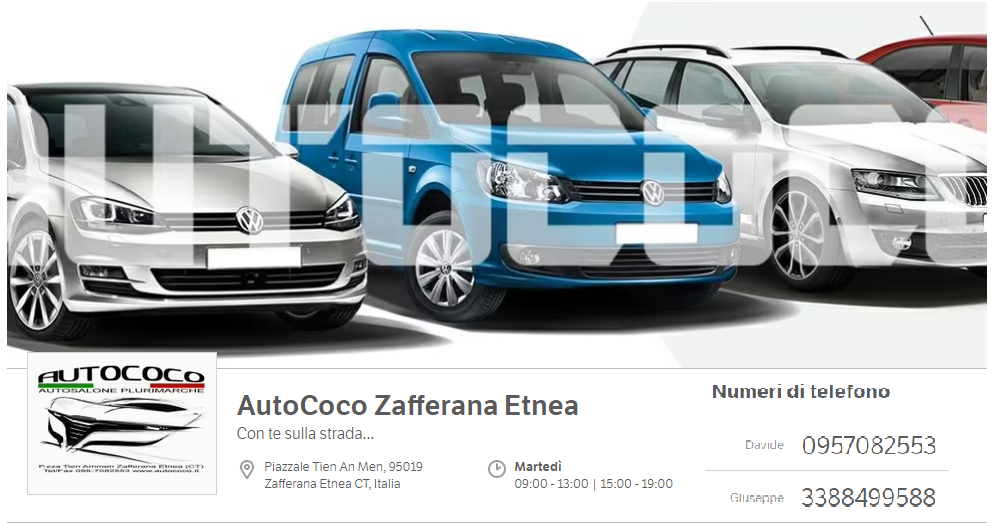È mite l’aria in questa notte di ottobre. Abbiamo da poco avuto due grossi sbarchi. Tanti profughi, tutti siriani. Da quando, in quello che un tempo era un Paese ricco e fiorente, è iniziata la guerra, ne arrivano sempre di più. Soprattutto famiglie. Il loro arrivo, fra l’altro, ha posto un problema non trascurabile. Perché organizzare la permanenza degli ospiti al centro di accoglienza tenendo conto delle grandi differenze etniche e religiose è abbastanza complicato. I ragazzini e le donne sole non possono essere alloggiati insieme ai maschi adulti o ai nuclei familiari. E la questione è seria, non si può fare finta che non esista. I siriani giunti con gli ultimi sbarchi sono ancora tutti in banchina in attesa che si decida la loro sistemazione e ci
resteranno a lungo, in quello che diventerà il giorno più triste che Lampedusa abbia mai conosciuto. Alle 7.30 del 3 ottobre ricevo al cellulare una telefonata dal comandante della capitaneria: «Dottore, per favore, venga subito in banchina. C’è stato un naufragio e ci sono tanti morti». «Sono già qui, comandante» rispondo. «Non me ne sono mai andato. Abbiamo appena finito con i due sbarchi di stanotte. Vi aspetto.» Trascorre un quarto d’ora. Al molo giunge una barca di otto metri. Quella di Vito Fiorino. Conosco bene Vito, fa il pescatore e accompagna quando può i turisti per mare. Questa notte, sulla Gamar, ne portava otto. Con lui c’è Grazia; viene spesso a Lampedusa nella bella stagione perché sua sorella qui gestisce un negozio. Vedo da lontano che sta piangendo. È stravolta. La sua diventerà la prima immagine simbolo di quella immane tragedia. Lei e Vito erano usciti per una battuta di pesca notturna alla Tabaccara, un luogo incantevole dove, quando fa buio, basta alzare gli occhi per godere di un cielo stellato indimenticabile. Solitamente, i turisti trascorrono l’intera notte in mare e, dopo aver dormito in barca, rientrano in porto il mattino successivo. Sulla Gamar stanno dormendo tutti quando, all’alba, il compagno di Grazia inizia a sentire in lontananza delle voci che crescono. Sembrano urla. «Saranno i gabbiani,» lo tranquillizza Grazia «oppure turisti più chiassosi di noi.» L’uomo, però, non si rasserena affatto e chiede a Vito di fare rotta verso il punto da cui paiono provenire quelle urla. Che, più si avvicinano, più diventano forti, nette. E, a poco a poco, davanti ai loro occhi si palesa una visione che ha dell’incredibile. Il mare è pieno di gente che chiede aiuto. E di corpi senza vita. E non si vede traccia di alcun barcone. Non si vede perché è affondato proprio all’imboccatura del porto. Oltre cinquecento persone in preda al panico a pochi metri dalla riva. Chi ha iniziato a nuotare, chi è annegato subito. Chi è rimasto intrappolato nella stiva e non ce l’ha fatta a uscire. La corrente ha trascinato i superstiti (e le vittime) verso l’Isola dei conigli, ed è lì che li trovano Vito e i suoi ospiti. Sulla Gamar, il caos. Mani, braccia, che si allungano cercando di afferrare quanti più naufraghi possibile. Uno dei turisti si getta più volte in acqua per aiutare questi disperati a raggiungere l’imbarcazione e affidarli a chi è a bordo. Quarantanove ne recuperano in tre ore. Di più, però, non possono salvarne: rischierebbero di colare a picco anche loro. Al molo arrivano tutti bagnati e unti di gasolio. Qualcuno lo medichiamo sul posto, altri li trasferiamo al pronto soccorso. Grazia continua a piangere, ininterrottamente. «C’è il mare pieno di morti, pieno di morti» ripete, incapace di credere a ciò che ha visto. E noi capiamo che il disastro è di proporzioni gigantesche. Trascorrono pochi minuti. Arriva un altro peschereccio. Il comandante, Raffaele, sbaglia la manovra e sbatte contro la banchina. Aiutiamo l’equipaggio a legare le cime alle bitte e saliamo a bordo. Raffaele sta tremando. Non l’ho mai visto in un simile stato: un uomo esperto di mare, che ha rischiato più volte di morire. «Pietro, è una vita che navigo» mi dice disperato «ma una cosa così non mi era mai capitata.» Ha con sé venti superstiti. Stanno tutti malissimo. Al contrario della Gamar, il suo peschereccio non ha una pedana che faciliti l’accesso a bordo. Per tirare su i sopravvissuti si è sporto dalla barca facendosi tenere per le gambe dai suoi marinai e ha iniziato ad afferrare per le braccia uomini e donne. «Molti però mi scivolavano via, perché erano completamente cosparsi di gasolio. Pareva avessero addosso del grasso» mi racconta, e non smette di tremare. «Quelli che non riuscivo a trattenere ricadevano in acqua e non riemergevano più. Pietro, ti giuro, ho provato a salvarne di più, ma non ci sono riuscito. È terribile, terribile...» Sulle reti, Raffaele ha caricato, invece, quattro corpi. Li controllo a uno a uno. Tre sono morti da qualche ora. Il quarto è di una ragazza molto bella. Raffaele continua a riferirmi ciò che ha visto. Non riesce a fermarsi. «Pietro, c’è un mare di morti» e scoppia in un pianto dirotto. «Ovunque, corpi che galleggiano. I vivi si aggrappavano a me. Ti giuro, è orribile.» Intanto che lui parla, io prendo tra le dita il polso della giovane donna. Al contrario degli altri non è in rigidità cadaverica, ma questo potrebbe solo significare che è morta da poco. Poi mi pare di sentire un battito. «Zitto» dico a Raffaele. «Stai in silenzio.» Presto maggiore attenzione. Il battito c’è. Impercettibile, ma c’è. Ancora un altro. Non è morta. La prendo in braccio e Raffaele, con una forza sovrumana, ci scaraventa tutti e due sulla banchina nonostante la fiancata della barca sia molto alta. Dobbiamo fare più che in fretta. Portiamo di corsa la ragazza al poliambulatorio e seguono venti minuti di delirio. La spogliamo. C’è chi la intuba, chi aspira l’acqua salata e il gasolio che le riempiono la bocca e i polmoni. Io e l’anestesista iniziamo a massaggiarla senza sosta. Premi, aspira, ventila. Premi, aspira, ventila. Una manovra rianimatoria dopo l’altra. Sembriamo avere in corpo una quantità di adrenalina inimmaginabile. Dopo venti, lunghissimi minuti, una traccia nel monitor: il suo cuore ricomincia a battere. Prima pianissimo, poi sempre più regolarmente. È impossibile. È un miracolo. Esultiamo tra le lacrime di gioia. Kebrat, così si chiama, è salva. La portiamo in ambulanza sulla pista da dove un elicottero la trasporterà a Palermo. Ho appena provato l’emozione più grande dei miei venticinque anni di soccorsi, ma non c’è il tempo per far festa. In mare, intanto, sono uscite le motovedette di tutte le forze dell’ordine presenti sull’isola. Ogni uomo e mezzo disponibile è ora nell’area del disastro. Torno in banchina, pronto ad accogliere altri sopravvissuti. Invece, iniziano ad arrivare soltanto i morti. In poche ore ne contiamo centoundici. Sul molo Favaloro è una lunga sequenza di sacchi verdi e neri. Giro attorno al primo sacco. Lo apro. Dentro c’è un bambino. È bellissimo. Indossa un paio di pantaloncini rossi. Così ben vestito, era pronto a iniziare la sua nuova vita. E invece i militari della motovedetta della guardia costiera l’hanno tirato su con il «mezzo marinaio». Galleggiava attorniato da otto cadaveri. L’hanno afferrato con una sorta di arpione che dovrebbe servire ad agganciare altre barche o a recuperare oggetti in mare e che oggi sta pescando soltanto corpi esanimi. Un bimbo talmente bello che sembra vivo. Lo prendo in braccio. Provo a scuoterlo per risvegliarlo. Gli tasto il polso. Stavolta, però, non avviene alcun miracolo. Inizio le ispezioni. Apro i sacchi uno per uno. Almeno venti di quei disgraziati tengono in bocca una catenina col crocifisso. Stretta fra i denti. Come se l’ultimo gesto prima di morire fosse stato quello di affidarsi a Dio. Da allora sognerò spesso quelle labbra serrate attorno alla croce. Dentro un sacco c’è una donna che ha appena partorito. Ha ancora il cordone ombelicale attaccato. Li metteremo insieme, nella cassa da morto, lei e il suo bimbo. E con loro un orsacchiotto di peluche. Le casse. Dove le troviamo tante casse? E poi, dove le mettiamo? In banchina con me c’è il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini. Facciamo arrivare sul posto dei camion frigorifero. E altre bare. Le sistemeremo tutte nella vecchia aerostazione e dentro l’hangar dell’aeroporto. Non abbiamo altra scelta. Quindici giorni e quindici notti. Scanditi dagli stessi incessanti ritmi. Le motovedette in mare a recuperare corpi. I sub sott’acqua a perlustrare i fondali e a cercare di svuotare il relitto da tutti quegli uomini, donne e bambini senza vita. E noi, in banchina prima e nell’hangar poi, a prelevare tessuti e frammenti ossei senza soluzione di continuità. Per dare un nome a trecentosessantotto sventurati. Con gli agenti della polizia scientifica che ci aiutano a sistemarli nelle casse. Con i medici legali inviati per supportarci, e che non riescono a reggere uno strazio difficile da sopportare persino per chi si è già dovuto confrontare con tanta sofferenza. A Lampedusa, in quei giorni, arrivano anche gli psicologi. Per sostenere i superstiti del naufragio e gli operatori impegnati nei soccorsi. A cominciare dai sommozzatori, che stanno subendo i traumi maggiori. Non è facile trovarsi davanti ai corpi incastrati nello scafo, ai volti senza vita di tanti bambini e bambine. Avrei bisogno anch’io di un supporto psicologico, ma nel mio caso non è previsto. Mi sento terribilmente solo e angosciato, ma non posso farmi prendere dallo sconforto. C’è ancora tanto, troppo lavoro da fare. Guardare i trecentosessantotto sacchi allineati nell’hangar era stato straziante. Metterli dentro le casse e sigillarle, ancora di più. Pochi giorni dopo, insieme al sindaco e al parroco prendemmo una decisione tutt’altro che scontata. Mandammo alcuni pullman a prelevare i sopravvissuti al centro di accoglienza, per consentire loro di dare l’ultimo saluto a familiari e amici. Appena giunsero, scoppiarono in un pianto sommesso. Ognuno gemeva su una bara, non importava chi ci fosse dentro. Poi, qualcuno iniziò a urlare per la disperazione. Fu un attimo: in quell’enorme cimitero improvvisato risuonò fortissima l’eco della tragedia. Il dolore esplose con tutta la sua potenza. Fu un’onda devastante. E noi capimmo all’improvviso di aver vissuto per settimane in apnea, in una condizione sospesa. Come se fossimo stati proiettati in un mondo virtuale che, invece, era molto più che reale. Ne stavamo, improvvisamente, prendendo coscienza. Aprimmo le porte dell’hangar e facemmo uscire i superstiti. Forse avevamo sbagliato: non erano pronti per confrontarsi con un’immagine così forte e brutale che non era solo la fine crudele dei loro compagni di viaggio ma anche l’atrocità del loro sogno di speranza. Il supplizio, il tormento, tornarono prepotenti nei giorni successivi. Al cimitero, dove molti lampedusani avevano deciso di accogliere nei loculi e nelle tombe dei loro cari le vittime di quella immensa sciagura. E al porto, dove madri, padri, sorelle, fratelli si prostravano su altri feretri, per cercare di bloccare le gru che li caricavano sulla nave diretta a Porto Empedocle. E poi, familiari giunti da tutta Europa che imploravano di poter almeno porre una foto accanto al numero che contrassegnava la cassa del loro congiunto. Lampedusa in quei giorni dovette utilizzare tutte le proprie forze per affrontare un’emergenza senza precedenti. L’isola intera stava reagendo in una vera maratona di solidarietà. Numerosissime famiglie avevano aperto le loro case per accogliere i sopravvissuti e si erano prese cura di loro, ma stavamo anche combattendo contro una burocrazia che, invece, non riusciva a dare risposte in tempi rapidi. In Comune e al poliambulatorio le urla del sindaco e le mie erano continue. Chiedevamo attenzione e aiuto concreto. Per mesi non riuscimmo a pensare ad altro. Il 3 ottobre, ne eravamo consapevoli, aveva cambiato per sempre la nostra storia. L’anno successivo, l’anniversario della strage fu celebrato non senza polemiche e contestazioni. Ci fu un momento di grande commozione quando arrivarono in aeroporto molti dei superstiti che da Lampedusa avevano raggiunto parenti e amici in diversi Paesi europei. Ad attenderli trovarono quei lampedusani che li avevano accolti e sostenuti. Abbracci, pianti: fu un momento emozionante e liberatorio. Non per tutti, però. In un angolo, all’aeroporto, c’ero anch’io. La porta scorrevole, nell’area degli arrivi, si apriva e chiudeva in continuazione. Vedevo i passeggeri correre incontro a chi li aveva adottati, anche se per poco tempo, subito dopo il naufragio. A ogni apertura della porta, la mia speranza a poco a poco scemava. Quando anche l’ultimo sopravvissuto varcò la soglia dell’aerostazione capii che il mio desiderio non si era avverato: Kebrat non era tornata. Non avrei riabbracciato quella splendida ragazza che avevamo strappato alla morte. Forse, non aveva avuto il coraggio di rivivere il dolore atroce che aveva provato. Aveva preferito rimanere in Svezia. Mi sentii invadere dalla tristezza. Poi mi feci largo tra le decine di troupe e microfoni che erano arrivati in massa, e me ne andai solitario verso casa.
- Bartolo, L. Tilotta, Lacrime di sale, Mondadori, Milano 2016, pp. 130-136.